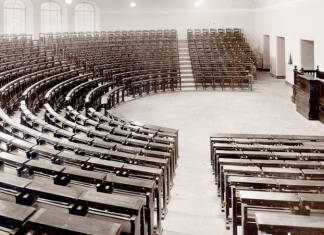Nella storia dell’arte occidentale, il contributo delle donne è stato per lungo tempo marginalizzato o relegato ai margini, nonostante fossero artiste di grande talento. Parlare dell’arte femminile vuol dire riconoscere come, fin dal Cinquecento, alcune pittrici abbiano fatto sentire la loro voce — spesso contro difficoltà sociali, istituzionali, culturali — e come, a partire dalla fine del XIX secolo, l’emancipazione abbia aperto spazi nuovi, fino a protagoniste del Novecento come Titina Maselli.
Nel periodo compreso tra il Cinquecento e l’Ottocento, i nomi femminili nel panorama artistico sono pochi, ma per nulla trascurabili. Un esempio emblematico è Artemisia Gentileschi, la cui opera ha iniziato solo recentemente ad essere ri-valutata dalla critica come centrale non solo per la sua bravura pittorica, ma per il coraggio di narrare la propria esperienza in un mondo dominato dagli uomini. In Italia, emerse anche Angelika Kauffmann, Maria Felice Tibaldi Subleyras, Louise Seidler fra le tante artiste presenti nella mostra Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo, che Palazzo Braschi ospita fino al 4 maggio 2025.
Questa mostra, che raccoglie oltre 130 opere di 56 artiste donne, alcune inedite o poco note, dimostra il ricco tessuto creativo femminile che Roma ha ospitato nei secoli. Le artiste non erano solo muse o figure secondarie, ma operavano attivamente, anche se in molti casi, a causa delle restrizioni sociali, non potevano partecipare pienamente al mercato o ottenere commissioni di rilievo.
Con la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, l’arte femminile assume una nuova consapevolezza. È in questo contesto che emerge Emma Ciardi, veneziana, nata nel 1879, la quale dedicò la sua carriera a paesaggi, vedute e soggetti settecenteschi che incontrarono un notevole favore fuori dall’Italia, specie in Inghilterra e negli Stati Uniti.
Fra le protagoniste futuriste, spicca Benedetta Cappa Marinetti, pittrice, scenografa e scrittrice. Moglie di Filippo Tommaso Marinetti, lei stessa fu allieva di Giacomo Balla e si distinse non solo per la sua adesione al movimento, ma per il proprio stile. Diede prova di grande autonomia creativa, sperimentando con la pittura, la scenografia e collaborando attivamente agli ideali futuristi.
Al di fuori dell’Italia, figure come Frida Kahlo offrono uno sguardo potente sull’arte femminile, capace di unire vita personale, identità, sofferenza e immaginazione visiva. Il loro esempio ha ispirato molte artiste italiane nel dopoguerra.
Nel contesto della Scuola Romana, emersero figure come Antonietta Raphael Mafai, Eva Quajotto, Katy Castellucci, che pur non avendo spesso la stessa fama dei loro colleghi maschi, produssero opere dense di significato, sperimentazione, sensibilità, spesso in dialogo con le correnti più aggiornate.
Dopo il 1945, con il secondo dopoguerra, l’impegno femminile in Italia si fece ancora più incisivo. Non si possono ignorare Carla Accardi, astrattista di grande spessore, cofondatrice di movimenti come Forma 1, impegnata nella ricerca del segno, della trasparenza, dell’interazione fra arte e spazio; Carol Rama, Bice Lazzari, Carla Badiali, e Giosetta Fioroni, che negli anni ’50 visse un soggiorno a New York e lì entrò in contatto con Andy Warhol, per poi tornare in Italia e dare vita a un linguaggio che anticipava il Pop.
È in questo quadro che assume un rilievo particolare Titina Maselli. Nata a Roma nel 1924, figlia del critico d’arte Ercole Maselli, e sorella del regista Francesco Maselli, ella sviluppò un percorso artistico autonomo che attraversa gran parte del Novecento con una libertà di stile non comune. Dall’esordio con nature morte, all’interesse per la vita urbana, gli atleti, le visioni urbane, i grattacieli, fino alla sperimentazione scenografica, Maselli fu capace di filtrare diverse correnti — Futurismo, Pop, Informale — senza mai essere “solo” aderente a una di esse.
L’antologica romana per il centenario della sua nascita, aperta dal dicembre 2024 al 21 aprile 2025 al Casino dei Principi di Villa Torlonia e al MLAC dell’Università la Sapienza, raccoglie circa cento opere che coprono i vari momenti della sua produzione, molte poco note o non viste da tempo. Questa retrospettiva segna non solo un momento celebrativo, ma una riconferma critica del suo posto tra le grandi artiste italiane del Novecento.
Nel corso del Novecento e specialmente dopo la guerra, le donne artiste hanno via via conquistato visibilità, pur restando spesso escluse dai circuiti dominanti del potere (gallerie, accademie, critici). Mostre come Roma Pittrice, Titina Maselli, Ninfa e Musa. Un secolo di femminile nell’arte contribuiscono oggi a restituire una narrazione più completa e pluralista.
Riconoscere il ruolo delle pittrici non è solo questione di storia dell’arte: significa anche interrogarsi su come i criteri del bello, del valore, del gesto artistico siano stati definiti, su che tipo di talenti siano stati ignorati, e su quale sapienza estetica sia rimasta nascosta. Titina Maselli è simbolo di questo lavoro di riscoperta: un’artista che ha dipinto “tutte le cose note ma non guardate abbastanza”.